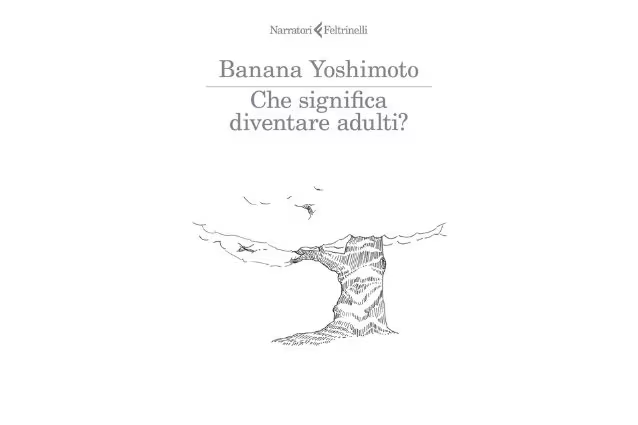Leggere fa bene, a volte semplicemente perché ci permette d’evadere per un po’ e distrarci da un presente faticoso. Però ci sono anche letture capaci di rivelarsi estremamente utili. Libri che ci accompagnano alla riflessione e ci aiutano a ragionare attorno a tematiche personali o condivise.
Alcuni sono decisamente complessi e richiedono conoscenze che non sempre si hanno. Ma una cosa è certa: nessuno libro ha la pretesa o la capacità di giudicare il nostro sapere pregresso, né le competenze possedute o non possedute in ambiti specifici.
Solitamente si legge nell’intimità, approfittando di un tempo che appartiene soltanto a noi e a chi, pur non conoscendoci, ha scritto affinché leggessimo. È un po’ come ascoltare una persona parlare: può capitare di trovarsi subito in sintonia, ma difficilmente coglieremo tutto ciò che ascoltiamo.
Dipende da noi, da loro, o semplicemente dal momento, ma in ogni caso ne sarà valsa la pena. Con i libri però viene meno la possibilità di controbattere, rispondere, aggiungere… il rapporto e lo scambio reciproco sono infatti impossibili a favore di ciò che oggigiorno è divenuto un fattore estremamente raro e perciò prezioso: il valore della la pausa.
Avere l’opportunità di sospendere, per tutto il tempo necessario, quello che è un ascoltare nel silenzio, un confronto a più dimensioni. Ci da l’opportunità di decidere quale sia il miglior momento per comprendere, per trasfigurare il punto di vista estraneo e atemporale e farlo nostro, adattandolo come un abito e intervenendo, con le giuste modifiche, come solo un sarto esperto saprebbe fare.
Qui troverai alcuni tra romanzi, saggi, poesie… che mi hanno incoraggiata a prendere la giusta direzione e a dare consistenza a certe idee o sensazioni che non riuscivo a interpretare nel modo corretto.
Non farò nessuna critica o recensione di opere altrui. Ti racconterò invece che cosa mi ha colpita e aiutata, nel mio percorso di vita, con la sincera speranza che possa ispirare anche te. Non m’interessa spingerti ad amare la lettura così come la amo io e nemmeno a convincerti ad acquistare le ultime novità che potrai trovare in libreria.
Come potrei, dal momento che quasi tutto ciò che acquisto è di seconda mano, prestato o addirittura trovato per caso? Ciò che m’importa davvero è darti dei suggerimenti con l’obiettivo che anche tu, possa ritrovarti nella tranquillità dei tuo spazi con un libro in mano o un e-book davanti agli occhi.
Se ti fa piacere, lascia traccia dei tuoi pensieri, di a me e alle altre lettrici, se c’è un libro che è riuscito a illuminarti, a farti sentire compresa, a ispirarti oppure incuriosirti.
Così, Cesare Pavese, annotava il 3 dicembre 1938:
Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati, che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Ci colpiscono degli altri le parole che risuonano in una zona già nostra — che già viviamo — e facendola vibrare ci permettono di cogliere nuovi spunti dentro di noi.
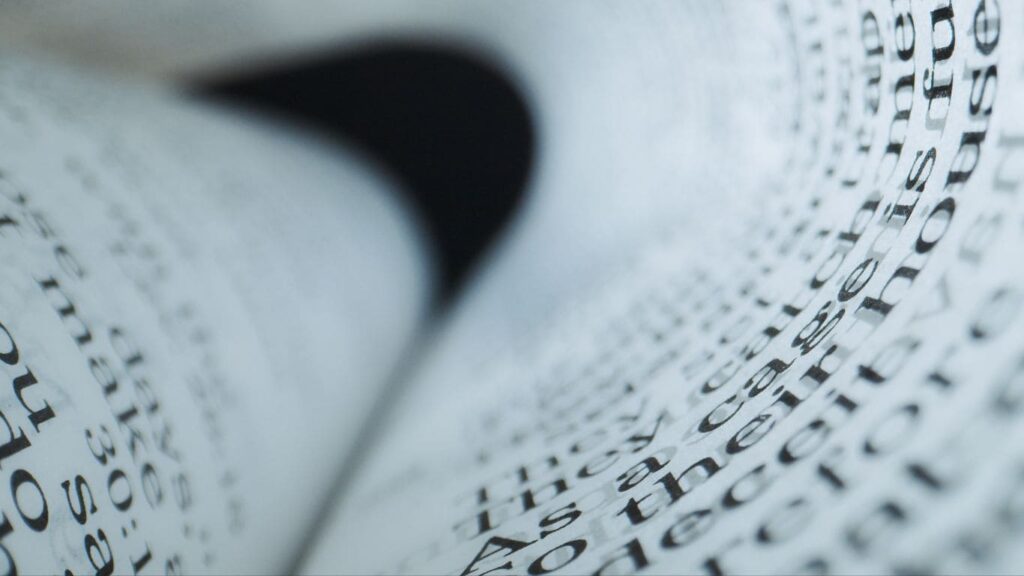
LETTERA SULLA FELICITÀ (Lettera a Meneceo)
Epicuro, dal greco Epíkouros, significa “soccorritore” o anche “alleato”. È sufficiente leggere la breve lettera che scrisse al suo amico, forse discepolo, Meneceo, per scoprire che non c’è nome più azzeccato di questo per un uomo che parlò con tanta incisività da far sì che il suo eco non si abbassasse di un solo tono. E ancor di più, perché ai nostri giorni, le sue riflessioni sulla felicità, continuano a ispirarci e a essere incredibilmente attuali.
Astenersi dal contestualizzare il suo pensiero o trascurare il momento storico in cui visse Epicuro significherebbe, tuttavia, commettere un errore grossolano come troppo frequentemente si verifica quando scriviamo o parliamo di filosofia.
Senza entrare nel dettaglio, è importante sapere che il filosofo di Samo visse nel IV secolo a.C. dopo l’età classica, dopo Socrate e Platone e tutti i grandi filosofi di quel periodo. Siamo nella Grecia ellenistica, quella del dominio macedone, della morte di Alessandro, del rafforzamento della schiavitù, della povertà e del diffuso disinteresse dei cittadini per il bene comune.
Gli intellettuali del tempo avevano due possibilità: dedicarsi alle discipline scientifiche oppure, come fecero i filosofi greci, chiudersi in loro stessi, ritirandosi dai posti affollati in cui erano stati protagonisti. E così Epicuro non parlava nelle piazze, né nelle scuole e in nessun altro luogo pubblico. Preferiva stare nel Kepos (il giardino), lontano dal chiasso cittadino, insegnando, immerso nella natura, a chiunque avesse voluto apprendere da lui (filosofi, acculturati, donne, schiavi).
Si esprimeva sulle sensazioni, le anticipazioni, i nomi, gli atomi, la saggezza, i dolori e soprattutto argomentava attorno al piacere che è:
“il principio e fine del vivere felicemente”
Non tutti i piaceri aprono le porte della felicità, come erroneamente si pensa dell’edonismo epicureo. Sono quelli stabili, che non si confondono con gli eccessi, e quelli dell’anima, capaci di dissipare il dolore (atarassia) e i turbamenti dello spirito.
Ad ogni età e per ogni essere umano, il piacere è principio e fine di una vita felice, e strumento fondamentale per discernere i desideri e scegliere di perseguire solo quelli realmente necessari al raggiungimento, appunto, della felicità.
Perché le idee di Epicuro sono utili? Cosa può fare la differenza nelle parole di un uomo vissuto ventitré secoli fa? Semplicemente il piacere — come punto di partenza (e anche di arrivo) — per valutare le decisioni, per costruire quel percorso personale che ci condurrà ai nostri obiettivi.
Siamo tutte talmente abituate a sorvolare sulle nostre sensazioni, ad azzittire la percezione del dolore a favore delle scelte dettate dal buon senso comune, da dimenticarci di noi stesse.
“Se ti opponi a tutte le sensazioni, non avrai più nemmeno criteri a cui riferirti e perciò neanche modo di giudicare quelle che tu dici essere errate.”
Inoltre, se ascoltassimo quel “bene primario” — così lo chiama Epicuro — il piacere, non soltanto staremo meglio con noi stesse, ma vivremo in accordo e armonia con gli altri. Scrisse Epicuro in una delle sue Massime Capitali:
“Diritto di natura significa patto fondato sull’utile reciproco, per non fare male agli altri e non riceverne”
Fai buon uso di queste indicazioni: leggi e rifletti, senza temere le conclusioni a cui arriverai. Sono tue.
Puoi leggere sia La lettera a sulla felicità che Massime capitali anche on line perché opere non soggette a diritti d’autore.
Buona lettura
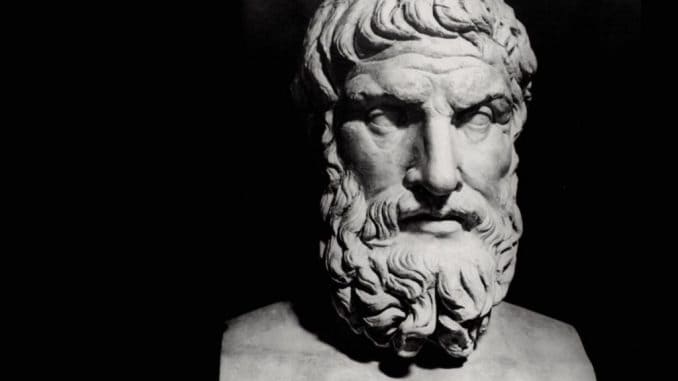
CHE SIGNIFICA DIVENTARE ADULTI?
C’è davvero tanto da dire su questo libro di Banana Yoshimoto, ma non credo di poter aggiungere nulla di realmente significativo. Ciò che vorrei, è invitarti a fare buon uso delle preziose riflessioni che questa stra-ordinaria scrittrice vuol condividere con tutti noi.
La sua brevità (meno di 100 pagine) a poco a vedere con il tempo che impiegherai per terminarlo. Avrai di sicuro voglia di riaprirlo, sfogliarlo, osservare le delicate illustrazioni di Akemi Goto, rileggere le pagine per te più significative e le farai tue perché parlano anche di te.
Per me, che sogno di arrivare anche solo a un decimo della sua bravura, l’onestà con cui antepone i suoi lettori a qualsiasi scelta che miri al semplice profitto, la rende ancora più ammirevole di quanto già non fosse.
Banana Yoshimoto parte da una premessa che sostanzialmente coincide con il finale:
“Non è necessario diventare adulti, l’importante è che rimaniate fedeli a voi stessi”
Potrebbe sembrarti una scelta di poco conto, ma non lo è per niente. Cominciare con una riflessione chiara e compiuta, mostra l’urgenza dell’autrice di comunicare con noi escludendo qualsiasi artificio stilistico. Mahoko, il suo vero nome, ha in mente di condividere con noi alcune tra le sue esperienze personali. A che scopo? Aiutarci, con semplicità e modestia, ad affrontare la vita senza perderci in un abisso.
In queste pagine, dai toni confidenziali, ci racconta la sua infanzia. La famiglia, la scuola, il rapporto con i genitori, le amicizie. Affronta senza eufemismi il tema della morte, della crescita e della normalità, fino a domandare: Qual’è il senso della vita?
“Questo libro potrebbe esservi di conforto un giorno” scrive, invitandoci a conservarlo come un amuleto e a rileggerlo in caso ci trovassimo scoraggiate e abbattute. È un dono per ognuna di noi perché i temi trattati, gli stati d’animo e le difficoltà di cui parla appartengono a tutti quanti.
La sofferenza ci aiuta a crescere se apre la strada ai Perché. Non dobbiamo mai smettere di porci domande e di essere tenaci di fronte alle difficoltà. Stringendo i denti, rimanendo ciò che siamo — senza essere schiacciate dal peso delle sovrastrutture — che è il presupposto fondamentale per diventare adulti e indipendenti.
Indipendente è chi riesce a risolvere almeno un problema senza chiedere aiuto ai suoi genitori, fratelli o sorelle.
Ed è così che crescere ci fa bene, anche se viene meno quel tipo di energia e velocità di reazione dei bambini. Da adulti, è possibile raggiungere una consapevolezza tale da permetterci di goderci il momento presente prendendoci cura di noi stessi nel modo che reputiamo giusto.
Se il senso della vita è portare a compimento noi stesse, essere utili agli altri, allora c’è tanto da faticare. Darsi da fare e impegnarsi costantemente orientando gli sforzi in direzione delle esperienze vissute è fare tesoro dell’unicità della nostra storia personale, ponendo nuovi traguardi senza mai rinnegare nulla del nostro passato.
Che significa diventare adulti? È un piccolo dono di Banana Yoshimoto. Come una cara, vecchia amica, è determinata ad aiutarci e a sostenerci con consigli efficaci e utili spunti di riflessione.
Non ci resta che leggerlo e rileggerlo, ancora e ancora, e imparare a pronunciare quella frase fondamentale che dice:
“Datti da fare”